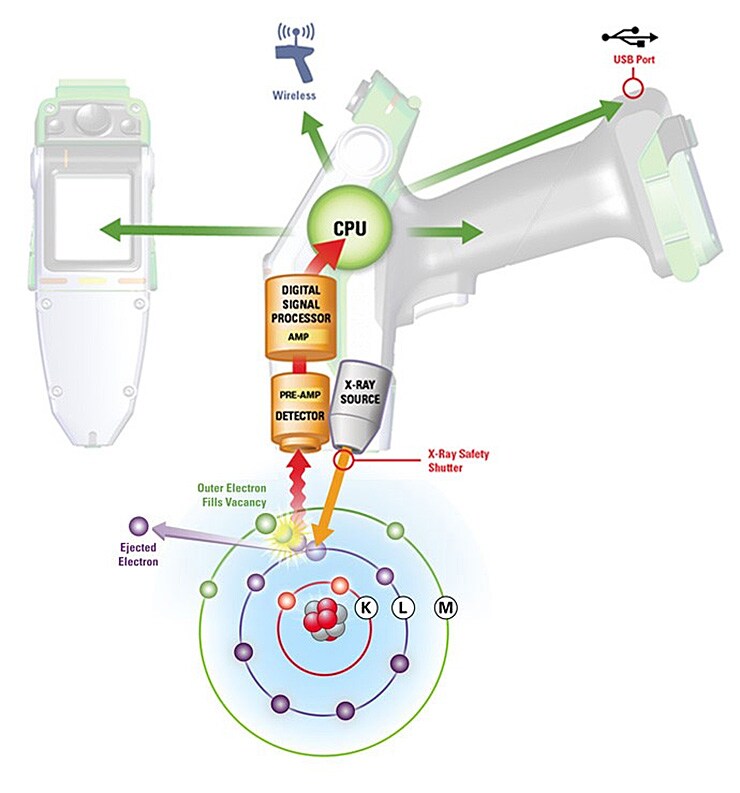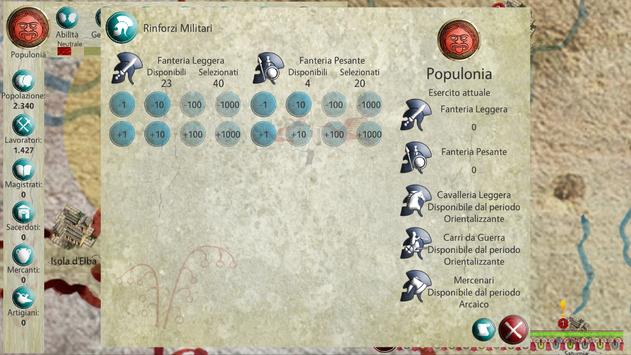In un articolo precedente avevo parlato di come la nostre vecchie strutture rurali (come le pinnette) abbiano la propria valenza come beni culturali, in quanto testimoni di un'epoca e di una tradizione pastorale che fanno parte della nostra storia, e dunque come manufatti da tenere in considerazione; nella sua introduzione avevo inoltre scritto che stavo preparando uno scritto da portare al Ruraland, convegno svoltosi presso il dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari. Dopo mesi e mesi ad aspettare, finalmente il mio lavoro viene pubblicato nella rivista ad esso dedicata, cosa che aspettavo da tempo dato che col copyright posso pubblicizzare il mio saggio senza il rischio che qualche simpatico furbacchione possa copiarla e spacciarla come propria.
Questo che leggerete sarà la sintesi dell'articolo al quale ho lavorato.
Come è noto a tutti, non è affatto raro trovarsi pinnette (capanne totalmente fatte di pietre, copertura compresa), muretti a secco e recinti per animali fatti di sassi in prossimità di siti archeologici, soprattutto quelli nuragici; in questo mio lavoro spiegherò la formazione del paesaggio rurale, il suo intersecamento con quello archeologico ed i motivi che lo creano. Cominciamo dal principio.
Le prime attività agro-pastorali in Sardegna si hanno a partire dal Neolitico antico e ci lasceranno tracce per tutta la preistoria e protostoria sarda, le più numerose di queste sono ossa di animali prettamente pastorali, come ovicaprini o suini, ed altri utilizzati nell'agricoltura, i bovini; vanno poi menzionati gli strumenti in pietra o in metallo utilizzati per l'agricoltura (come il falcetto in bronzo nuragico presente al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari) vasi per contenere derrate alimentari (dolii con anse a X, sempre nuragici e sempre al museo di Cagliari in questione) e di silos rinvenuti nel villaggio prenuragico di Su Coddu - Canelles, Selargius (CA).

Dolio nuragico con anse a "X"
Nell'area che ho analizzato, le prime strutture propriamente pastorali appartengono in tutta probabilità al periodo romano e si trovano in località Benezziddo, al comune di Aidomaggiore (OR): si tratta di due capanne allungate della stessa tipologia di quelle presenti al santuario nuragico di Santa Cristina a Pulilatino (OR), un tipo di strutture usate in tutta probabilità come ricovero degli animali. Dopo molti secoli, in periodo storico successivo a quello romano, abbiamo la costruzione di alcune pinnette di cui abbiamo resti sempre a Benezziddo e nelle località Bernardu Pala,
Mura Era, Sanilo, Abbaeras, Crabia e Urba ‘e Oes, sempre nel comune di Aidomaggiore; la particolarità è sempre quella di essere costruite in prossimità di siti nuragici. Pertanto in questo periodo si può parlare di una influenza del paesaggio archeologico su quello rurale in quanto i pastori sfruttano la presenza di villaggi e nuraghi per ottenere le pietre necessarie con cui innalzare le loro piccole capannette, pertanto la modifica del primo per opera del secondo è relativamente leggera.
Pinnetta rinvenuta a Benezziddo, Aidomaggiore.
Lo spartiacque, quello che darà inizio al vero e proprio intrecciarsi dei due paesaggi, lo si avrà in periodo sabaudo, nel 1823, quando verrà emanato il Regio editto delle Chiudende, che prevedeva che chiunque fosse riuscito a recintare un lembo di terra ne sarebbe diventato il proprietario; questa geniale trovata, oltre ad essersi rivelata un fiasco colossale, ebbe conseguenze devastanti sulla quasi totalità dei siti archeologici e sul loro stato di conservazione: molti siti archeologici, come i nuraghi e le necropoli romane ad incinerazione, subiranno danni irreversibili, tanto che alcuni di questi scompariranno del tutto o perderanno per sempre pezzi importanti facenti parte del loro contesto (abitati, segnacoli, menhir et cetera).
Lo spartiacque, quello che darà inizio al vero e proprio intrecciarsi dei due paesaggi, lo si avrà in periodo sabaudo, nel 1823, quando verrà emanato il Regio editto delle Chiudende, che prevedeva che chiunque fosse riuscito a recintare un lembo di terra ne sarebbe diventato il proprietario; questa geniale trovata, oltre ad essersi rivelata un fiasco colossale, ebbe conseguenze devastanti sulla quasi totalità dei siti archeologici e sul loro stato di conservazione: molti siti archeologici, come i nuraghi e le necropoli romane ad incinerazione, subiranno danni irreversibili, tanto che alcuni di questi scompariranno del tutto o perderanno per sempre pezzi importanti facenti parte del loro contesto (abitati, segnacoli, menhir et cetera).
Il motivo di tutte queste distruzioni è semplice: per costruire nel più breve tempo possibile, invece di spaccarti le mani a scolpire legno e pietra, prelevi il prodotto già finito e che sta a tua completa disposizione, ovvero i monumenti ed i siti archeologici: nuraghi, capanne antiche e contenitori in basalto romani per le urne forniscono un materiale solido, facilmente trasportabile e pronto al riuso. Da questo periodo comincerà quindi un processo inverso: l'influenza del paesaggio rurale su quello archeologico. Altre attività che andranno ad incidere notevolmente sullo stato di conservazione dei siti archeologici saranno le varie attività di spietramento del suolo e del sottosuolo in modo tale da rendere i terreni più sgombri e fertili per i pascoli di pecore e bovini, creando dei cumuli di pietra in cui non è improbabile ritrovarci pietre di muretti a secco facenti che in passato facevano parte di capanne, altre strutture interrate o nuraghi. Si assiste così anche ad un cambio di vedute in quanto il sito archeologico non viene più visto come una fonte di materiali di costruzione ma come un ostacolo che rende meno produttivo il terreno.
Nuraghe Su Fangarzu, Borore, in prossimità di muretti a secco e cumuli di pietra
Nuraghe Su Fangarzu, Borore, in prossimità di muretti a secco e cumuli di pietra
Concludo dicendo che ciò vi ho riportato non è frutto di ignoranza o vandalismo ma semplicemente dettato dalla necessità di adattarsi e sopravvivere da parte di persone (tra le quali potrebbero esserci parenti vostri e nostri) che altrimenti non avrebbero trovato modo per campare se stessi e le loro famiglie; occorre dunque porre la costruzione dei muretti a secco e delle pinnette nell'adeguato contesto se si vuole inserire il paesaggio rurale in un quadro culturale che entri in continuità con quello archeologico.
Per chi fosse interessato al mio articolo completo, ecco il link.
E voi cosa ne pensate? Se volete esprimere una vostra opinione non fatevi problemi, commentate!
Ci si vede ;)